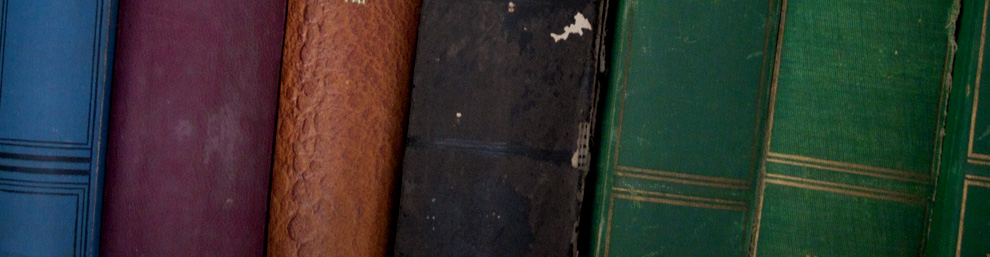‘Legacies of Ewan MacColl’, my book edited with Allan F. Moore, is coming soon… it will contain a number of critical essays but, most of all, the latest and longest interview Ewan ever released and that I recorded in 1987 and 1988!
Contercultures and popular music
Just published… A book edited by Sheila Whiteley and Jedediah Sklower, for Ashgate, on popular music and coontercultures, with my essay Music and Countercultures in Italy: The Neapolitan Scene (already in French on the magazine Volume!, 2012).

Legacies of Ewan MacColl
I have the pleasure to announce that, after a long and hard work, Ashgate has scheduled for November my book Legacies of Ewan MacColl (co-edited with the English musicologist Allan F. Moore). It contains the text of the long interviews I did with the great British folksinger in 1987 and 1988 and also includes some critical essays that contextualize MacColl’s work in music and theatre and discuss his political activities, that started in the ‘3os and only ended with his death. This book is a historical document not only because it’s MacColl’s last and longest interview but also because it goes through a century of British history seen ‘from below’. Legacies of Ewan MacColl opens with a preface written by Peggy Seeger and it will be published on the occasion of twenty-five years after MacColl’s death. For details see the link
Songs and the city
This is the text of my paper given at the Seminar of Ethnomusicology held at the Fondazione Cini in Venice on 30, 31 January and 1 February 2014. The words in bold refer to images projected on a screen. The appendix is made of contents not utilized during the discussion.
Pete Seeger
Pete Seeger died yesterday at 94. I’ve always been a friend of the Seeger family since the ’80s, when I met Peggy and Ewan MacColl in England. This is the last postcard I got from Pete when he turned 90 and I interviewed him for Il Manifesto newspaper (the pdf interview, in Italian, on this website in the section ‘articoli’, dated 2009). There is no need to say anything about Pete, such a giant he was. I’ve written a message to Peggy.
Fare thee well, Pete, may God bless you!